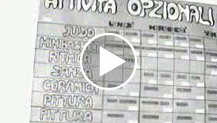- 1815
- 1870
- 1914
- 1922
- 1940
- 1945
- 1961
- 1991
-
- 1862
-
- 1870
verso-roma
-
- 1903
-
- 1914
eta-giolittiana
-
- 1961
- il-centrosinistra
-
- 1968
- il-biennio
-
- 1970
- anni-violenti
-
- 1985
-
- 1990
il-declino-della-prima-repubblica
-
- 1991
- tra-due-repubbliche
-
- 2007
-
- 2010
una-lunga-transizione
La scuola
L'organizzazione della scuola su basi unitarie e laiche costituisce una delle prime preoccupazioni del Regno d'Italia. Inizialmente, lo Stato si impegna nella costruzione di una rete di scuole secondarie, fondamentale per dar vita a un ceto medio nazionale capace di garantire l'amministrazione e lo sviluppo del Paese, mentre affida ai comuni le redini della scuola elementare. Con la riforma del 1923, il Fascismo valorizza la conoscenza del latino come elemento culturale distintivo della nazione italiana, affida all'istruzione tecnico-scientifica un ruolo poco più che strumentale, riduce il coinvolgimento dello Stato nella costellazione delle scuole professionali, mentre assegna alle scuole elementari compiti di educazione ai valori del regime. L'Italia repubblicana è chiamata a confrontarsi con l'esplosione di una domanda di istruzione di massa che ha una risposta forte in rapporto al triennio postelementare che con il 1962 diventa unico, obbligatorio e senza latino. Per le scuole secondarie e per l'università iniziano i decenni delle parziali aperture e delle continue sperimentazioni. Oggi la scuola è chiamata a favorire i processi di inclusione in un'Italia multiculturale e multietnica, nel segno di un'educazione alla cittadinanza attiva e consapevole.
La scuola della legge Casati
Nato da un movimento nazionale interessato a potenziare l'istruzione del popolo e la formazione civile dei nuovi ceti borghesi, costretto a misurarsi con una Chiesa ostile e decisamente egemone nel campo dell'educazione, fino dall'inizio il Regno d'Italia fa della costruzione di un sistema di istruzione pubblica, laico e capillarmente diffuso, uno dei suoi obiettivi di fondo. A regolarne la costruzione è la legge Casati, varata il 13 novembre 1859 e rimasta in vigore nel suo impianto complessivo fino al 1923. La legge Casati disegna una piramide rovesciata, al cui vertice sta l'università, seguita dall'istruzione secondaria, e cioè dall'istruzione classica e da un istituto tecnico articolato in più rami e aperto ai corsi universitari di ingegneria. Il gradino più basso, quello dell'istruzione primaria (che avrebbe dovuto costituire l'investimento maggiore di uno Stato nazionale alle prese con un tasso di analfabetismo che nel 1861 riguarda oltre il 72% degli italiani e quasi l'87% delle italiane) è affidato alle competenze amministrative dei Comuni, mentre le scuole per formarne gli e le insegnanti (dette «normali») vengono presentate come semplici scuole professionali.
Scuola e nazione
Bisogna aspettare l'avvento della Sinistra perché lo Stato si impegni a promuovere l'obbligo scolastico (legge Coppino, 1877), a migliorare le condizioni dei maestri (e soprattutto delle maestre), a istituire una rete di piccole scuole di arti e mestieri che rendano più vicina la scuola almeno ai ceti popolari urbani. Solo con l'aprirsi del nuovo secolo «la scuola del popolo» diventa oggetto di un interesse attivo da parte di vasti ceti popolari e di un robusto impegno (anche finanziario) dello Stato, fino al varo nel 1911 della legge Daneo-Credaro, che fissa il passaggio allo Stato delle scuole elementari con ciò stesso riconoscendo la rilevanza «nazionale» e «nazionalizzante» della formazione di base dei futuri cittadini.
La scuola fascista
Nel 1923 la riforma Gentile modifica in profondità la struttura dell'amministrazione scolastica, accentuandone i poteri di controllo e di intervento, in particolare con l'introduzione di vicoli ciechi e rigide canalizzazioni nella scuola secondaria e l'accentuazione del valore strategico e simbolico del latino. Soggetta ben presto a un'intensa «politica dei ritocchi» e sopraffatta da un'impetuosa fascistizzazione degli spazi e dei tempi, la scuola della riforma Gentile viene infine modificata dalla Carta della scuola, varata da Bottai nel 1939-1940, che - oltre a valorizzare il lavoro manuale «educativo» - istituisce un triennio unico con latino valido per l'accesso al ginnasio-liceo, all'istituto magistrale e a quello tecnico.
Continuità e rotture nella scuola della Repubblica
Nell'Italia del dopoguerra e del boom economico, il tumultuoso affermarsi di un Paese dominato dall'industria, dai commerci e dai servizi, l'esplosione della domanda scolastica prima nell'ambito delle medie inferiori (unificate nel 1962) e poi in quello delle superiori, il divario crescente tra la cultura scolastica e quella delle giovani generazioni conducono alla radicale messa in discussione della scuola in quanto tale. Come accade, in particolare, con la contestazione studentesca esplosa nel Sessantotto e proseguita a singhiozzo per vari anni, che conduce sì a una democratizzazione delle scuole secondarie e delle università (pensiamo al libero accesso all'università a partire da ogni tipo di scuola secondaria, o alla liberalizzazione dei piani di studio universitari), ma anche a una loro sostanziale disarticolazione.
Quale scuola?
Proprio la difficoltà di governare e gestire un universo tanto complesso invita a valorizzare il principio dell'autonomia che, introdotto nei «decreti delegati» del 1974 (con cui si fissavano forme e competenze di organi collegiali rappresentativi delle diverse componenti scolastiche), è divenuto la parola d'ordine di questi ultimi venti anni, dal progetto di riforma Berlinguer del 1997 a quello Moratti del 2003, fino alle leggi Gelmini del 2010. Senza peraltro riuscire a trasformarsi - in assenza di investimenti economici e di una progettualità all'altezza della sfida dei tempi - in un orizzonte capace di favorire quei processi di acculturazione e di integrazione civica che sono indispensabili al buon funzionamento di una società atomizzata e multietnica al tempo stesso.